 Oh, ero proprio convinta di riuscirci, sapete?
Oh, ero proprio convinta di riuscirci, sapete?
In fondo non sarebbe stata la prima volta: scadenza incombente, indietro come un carro di refe, scriverescriverescrivere per un certo numero di giorni… E si sa, non lavoro mai così bene come quando sono sotto pressione, giusto?
E dunque, quando all’inizio di gennaio (ugh!) mi sono ritrovata a due settimane dalla scadenza, mi son detta: che sarà mai? Da oggi mi ci metto d’impegno, e…
…E a dire il vero, il giorno in questione l’impegno si è limitato a una rilettura del materiale che avevo pronto. E me ne son venuta via con qualche appunto in più, qualche scintilla di rinnovato fuoco in proposito – e la constatazione che di materiale non ce n’era poi molto.
Hm.
Ma da domani…
E l’indomani mattina c’erano cose irrinunciabili da fare, e ilpomeriggio… dov’è che vanno mai a finire questi pomeriggi invernali? E a sera mi sono seduta al computer, e ho trafficato con i miei appunti, e scritto due versioni di un pezzo, e deciso che potevo tenerle tutte e due – a patto di sviluppare una certa idea in una direzione diversa, e… oh, guarda sono le due e un quarto del mattino!
E via così nei giorni successivi, riducendomi a lavorarci a notte tarda, e trovando una nuova possibilità dietro l’altra, e aggiungendo liste, domande, link, idee da esplorare, punti strutturali da approfondire… tutto fuorché conteggio parole.
Dite la verità: a voi che cosa sembra?
Io non ci ho nemmeno fatto troppo caso, finché le due settimane di tempo non si sono ridotte a poco più di una, e mi sono accorta che avevo ben poco di pronto. Quasi nulla, in realtà. Un’idea che mi piace molto, un sacco di appunti, e un maiuscolo caso di procrastinazione.
E allora mi sono fermata a pensare. Il concorso di cui parliamo è una faccenda sull’Isoletta, a proposito di una forma che per me è in parte nuova e in parte non proprio nuova ma un nonnulla ostica. All’inizio del Terribile Venti mi ero proposta, a titolo di progetto annuale, di dedicarmi alla forma in questione, lavorarci con costanza e produrre qualcosa che si potesse mandare al concorso isolano. Buoni propositi, you know…
E così ho cominciato, e ho seguito qualche corso in proposito su Skillshare e altrove, e ho trovato un’idea che mi piaceva, e quando ho visto che, dopo qualche mese, la faccenda aveva l’aria di non andare da nessuna parte, ho cercato di darmi uno scrollone iscrivendomi a Story A Day, e la cosa ha sortito qualche effetto – e poi naturalmente ci sono stati la stagione estiva a Palazzo d’Arco, e Road to Murder, e il Rumore delle Ali…
Ma l’idea del concorso era sempre lì, e mi sembrava di avere tutto il tempo del mondo, perché andiamo! Gennaio del Ventuno? Tutto il tempo del mondo.
Well, yes: quando ho consegnato Road to Murder all’editore a fine novembre, persino io mi sono accorta che dicembre (che è dicembre!) e parte di gennaio non erano più tutto il tempo del mondo – ma a quel punto non mi restava più tantissimo da fare. Avevo più o meno tre quarti di prima stesura, si trattava soltanto di finire e strutturare per bene. Fattibile, giusto? Fattibilissimo.
A patto di non decidere all’improvviso che quei tre quarti di prima stesura non andavano più bene. Che mancavano di… qualcosa – qualcosa. Che c’era un’altra idea migliore – completamente nuova e in parte da ricercare – ma perfetta…
Yes, well.
Lo so. Ma siccome ho il buon senso di una meletta acerba, via sull’onda del nuovo entusiasmo, tra una decorazione natalizia e l’altra: ricerche, appunti, freewriting, tempeste cerebrali… Fino a Natale.
Voi scrivete i giorni di Natale? Io no. Ogni tanto, mentre leggoleggoleggo accanto al camino con un gatto sulle ginocchia e una tazza di tè a portata di mano, ci penso, mi sento vagamente in colpa, ma poi non ne faccio nulla.
E poi all’improvviso è stato gennaio (ugh!), e la scadenza incombeva, e io avevo soltanto un’idea e pagine su pagine di appunti e il maiuscolo attacco di procrastinazione…
E probabilmente avrei potuto farcela. Facendo le corse, scrivendo giorno e notte, accantonando tutto il resto. L’ho già fatto in precedenza, giusto? Più di una volta. Con successo. Sono capace di farlo. L’ultima volta che l’ho fatto, ho anche vinto il concorso in questione…
Solo che stavolta non l’ho fatto. Stavolta ho guardato per bene il calendario e le mie pagine di appunti e sondato le profondità del mio attacco di procrastinazione, e rimuginato sul fatto che da un anno lavoro a questa cosa e non vado da nessuna parte – e ho deciso di fermarmi.
Di non forzare la faccenda, di non mandare sull’Isoletta qualcosa di cotto a metà, di cercar di capire perché, quando si tratta di questa particolare forma, sviluppo tutta questa capacità di autosabotaggio. Fine della storia.
Forse, dopo tutto, non ero poi così convinta di riuscirci.
Forse accantonerò il progetto e forse no. Forse è segno che sto maturando e forse invece è un pessimo precedente. Non lo so ancora. Vedremo. Intanto niente concorso – e non so, ma non mi sembra il modo migliore per iniziare l’anno nuovo…
Vedremo.
Ve l’ho mai detto che detesto gennaio?


 Una curiosa e antichissima tradizione vuole che, dal tipo di agrifoglio che viene portato in casa, si possa divinare quale dei coniugi avrà più autorità in casa durante l’anno a venire. Il fatto è che l’agrifoglio è maschio e femmina, e qui le cose si complicano. Secondo la mia fonte austriaca per questa storia, l’agrifoglio femmina è quello con le bacche rosse, più bello e decorativo e quindi scelto quasi invariabilmente, per cui la tradizione sarebbe una specie di omaggio al fatto che è sempre la donna a governare la casa. Questa teoria però mal si concilia con cose come la carola natalizia di origine medievale
Una curiosa e antichissima tradizione vuole che, dal tipo di agrifoglio che viene portato in casa, si possa divinare quale dei coniugi avrà più autorità in casa durante l’anno a venire. Il fatto è che l’agrifoglio è maschio e femmina, e qui le cose si complicano. Secondo la mia fonte austriaca per questa storia, l’agrifoglio femmina è quello con le bacche rosse, più bello e decorativo e quindi scelto quasi invariabilmente, per cui la tradizione sarebbe una specie di omaggio al fatto che è sempre la donna a governare la casa. Questa teoria però mal si concilia con cose come la carola natalizia di origine medievale  In effetti, nei culti druidici di ambito celtico, l’agrifoglio era associato al solstizio d’inverno e al vigore maschile, e già che c’era teneva lontani i demoni. Con l’arrivo dell’inverno, se ne portavano in casa rami e ghirlande a mo’ di evil-detector: si supponeva che gli esseri fatati benevoli venissero a giocare tra le foglie, mentre quelli poco raccomandabili si sentivano tenuti a starsene alla larga. L’agrifoglio era la pianta del Re d’Inverno, a mezza strada tra un’entità fatata e una divinità infera, un gigante bellicoso che regnava per metà dell’anno, incoronato di rosso e armato di un ramo di agrifoglio. Non avrei detto che, spine a parte, fosse un’arma particolarmente efficace, eppure nel Ciclo Arturiano il Re d’Inverno ricompare nella forma del Cavaliere Verde, che sfida a duello Galvano, armato soltanto di quello.
In effetti, nei culti druidici di ambito celtico, l’agrifoglio era associato al solstizio d’inverno e al vigore maschile, e già che c’era teneva lontani i demoni. Con l’arrivo dell’inverno, se ne portavano in casa rami e ghirlande a mo’ di evil-detector: si supponeva che gli esseri fatati benevoli venissero a giocare tra le foglie, mentre quelli poco raccomandabili si sentivano tenuti a starsene alla larga. L’agrifoglio era la pianta del Re d’Inverno, a mezza strada tra un’entità fatata e una divinità infera, un gigante bellicoso che regnava per metà dell’anno, incoronato di rosso e armato di un ramo di agrifoglio. Non avrei detto che, spine a parte, fosse un’arma particolarmente efficace, eppure nel Ciclo Arturiano il Re d’Inverno ricompare nella forma del Cavaliere Verde, che sfida a duello Galvano, armato soltanto di quello. Questo carattere guerresco dell’agrifoglio, insieme alla capacità di scacciare il male, ricompare pari pari nei miti giapponesi, i cui dei ed eroi desiderano la pianta dalle bacche rosse e si forgiano armi prodigiose con il suo legno. O almeno manici di armi prodigiose, come nel caso del Principe Yamato (che comunque non fa una gran bella fine) e Daikoku, che tiene lontani i demoni scuotendo rami di agrifoglio. In Giappone si appendono rami di agrifoglio per buona fortuna, proprio come da questa parte del mondo – a dimostrazione del fatto che certe simbologie sono universali.
Questo carattere guerresco dell’agrifoglio, insieme alla capacità di scacciare il male, ricompare pari pari nei miti giapponesi, i cui dei ed eroi desiderano la pianta dalle bacche rosse e si forgiano armi prodigiose con il suo legno. O almeno manici di armi prodigiose, come nel caso del Principe Yamato (che comunque non fa una gran bella fine) e Daikoku, che tiene lontani i demoni scuotendo rami di agrifoglio. In Giappone si appendono rami di agrifoglio per buona fortuna, proprio come da questa parte del mondo – a dimostrazione del fatto che certe simbologie sono universali. Il Cristianesimo assorbì pianta e significati simbolici con giustificabile entusiasmo: abbiamo già detto che l’agrifoglio è scenograficamente perfetto. Secondo una leggenda, l’agrifoglio avrebbe avuto in origine bacche bianche, diventate rosse dopo che i suoi rami furono usati per la corona di spine di Gesù; oppure sarebbe stato deciduo fino a quando durante la fuga in Egitto, la Madonna non pregò Dio di restituire le foglie all’arbusto dietro cui si nascondeva col Bambino Gesù, per nascondere entrambi alla vista dei soldati di Erode. Altre leggende associano l’agrifoglio a una variante del collaudato schema narrativo del Dono del Pastore: in queste storie c’è sempre un pastorello particolarmente povero che giunge alla capanna con un dono vegetale del tutto inadeguato, oppure non ha il coraggio di avvicinarsi per mancanza di dono. A questo punto un intervento miracoloso consente al pastorello di arrivare portando una rarità botanica. Nel caso dell’agrifoglio Gesù Bambino trasforma la corona di alloro del pastorello in una ghirlanda dalle foglie lustre e dalle bacche scarlatte; in una
Il Cristianesimo assorbì pianta e significati simbolici con giustificabile entusiasmo: abbiamo già detto che l’agrifoglio è scenograficamente perfetto. Secondo una leggenda, l’agrifoglio avrebbe avuto in origine bacche bianche, diventate rosse dopo che i suoi rami furono usati per la corona di spine di Gesù; oppure sarebbe stato deciduo fino a quando durante la fuga in Egitto, la Madonna non pregò Dio di restituire le foglie all’arbusto dietro cui si nascondeva col Bambino Gesù, per nascondere entrambi alla vista dei soldati di Erode. Altre leggende associano l’agrifoglio a una variante del collaudato schema narrativo del Dono del Pastore: in queste storie c’è sempre un pastorello particolarmente povero che giunge alla capanna con un dono vegetale del tutto inadeguato, oppure non ha il coraggio di avvicinarsi per mancanza di dono. A questo punto un intervento miracoloso consente al pastorello di arrivare portando una rarità botanica. Nel caso dell’agrifoglio Gesù Bambino trasforma la corona di alloro del pastorello in una ghirlanda dalle foglie lustre e dalle bacche scarlatte; in una 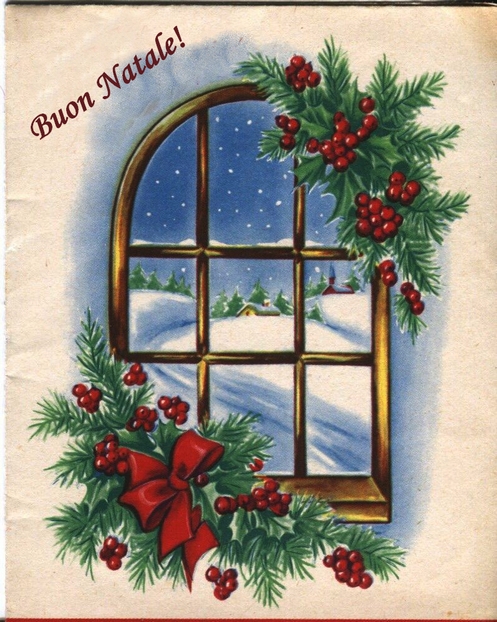




 E se vi dicessi che il Teatrino d’Arco, benché chiuso, non è fermo?
E se vi dicessi che il Teatrino d’Arco, benché chiuso, non è fermo?
 Questo è il problema. Se sia meglio portare il fantasma in scena come uno spirito incarnato o suggerire la sua incorporeità per mezzo di luci blu, velari e macchina della nebbia – o magari non mostrarlo affatto. Spettro, apparizione, voce disincarnata, ossessione folle – e con un’idea registica dire che si è messo fine al dibattito sulla natura dell’ectoplasma vendicativo…
Questo è il problema. Se sia meglio portare il fantasma in scena come uno spirito incarnato o suggerire la sua incorporeità per mezzo di luci blu, velari e macchina della nebbia – o magari non mostrarlo affatto. Spettro, apparizione, voce disincarnata, ossessione folle – e con un’idea registica dire che si è messo fine al dibattito sulla natura dell’ectoplasma vendicativo…
 E la questione cessa di sembrare di lana caprina quando si guarda che cosa ne fa Shakespeare, portando in scena il fantasma di Amleto senior. Bernardo e Marcello, i primi a vederlo, non sanno bene che cosa pensarne ma, a ogni buon conto, chiamano e mandano avanti Orazio, perché Orazio sa il Latino e quindi è in grado di conversare con l’apparizione – e presumibilmente scacciarla, se necessario.
E la questione cessa di sembrare di lana caprina quando si guarda che cosa ne fa Shakespeare, portando in scena il fantasma di Amleto senior. Bernardo e Marcello, i primi a vederlo, non sanno bene che cosa pensarne ma, a ogni buon conto, chiamano e mandano avanti Orazio, perché Orazio sa il Latino e quindi è in grado di conversare con l’apparizione – e presumibilmente scacciarla, se necessario.
 In termini di pratica teatrale, la faccenda si traduceva in un attore in armatura che entrava in scena (da destra o da sinistra?), faceva le sue declamazioni con voce stentorea**** e poi si affrettava a cambiarsi per interpretare un’altra particina o due.
In termini di pratica teatrale, la faccenda si traduceva in un attore in armatura che entrava in scena (da destra o da sinistra?), faceva le sue declamazioni con voce stentorea**** e poi si affrettava a cambiarsi per interpretare un’altra particina o due.
 Ora, non è che questo ingentilimento e questa rarefazione dello spettro avessero eliminato del tutto l’opzione diavolo-cadavere-animato/posseduto, che ricompariva periodicamente nella forma di fantasmi-scheletri o fantasmi-zombi. E tuttavia, la tendenza ebbe uno sviluppo logico in altre direzioni: lo spettro scomparve del tutto quando i registi cominciarono a ipotizzare che non fosse un fantasma affatto – ma un caso di possessione, una proiezione dell’inconscio di Amleto o un sintomo della sua follia.
Ora, non è che questo ingentilimento e questa rarefazione dello spettro avessero eliminato del tutto l’opzione diavolo-cadavere-animato/posseduto, che ricompariva periodicamente nella forma di fantasmi-scheletri o fantasmi-zombi. E tuttavia, la tendenza ebbe uno sviluppo logico in altre direzioni: lo spettro scomparve del tutto quando i registi cominciarono a ipotizzare che non fosse un fantasma affatto – ma un caso di possessione, una proiezione dell’inconscio di Amleto o un sintomo della sua follia. Parlando con C. mi è albeggiata in mente una cosa: sono secoli che non propongo Gente nei Guai, il mio corso di scrittura narrativa. E mi è albeggiato in mente anche questo: se lo rifacessi? Online?
Parlando con C. mi è albeggiata in mente una cosa: sono secoli che non propongo Gente nei Guai, il mio corso di scrittura narrativa. E mi è albeggiato in mente anche questo: se lo rifacessi? Online? Ricordate come lamentavo,
Ricordate come lamentavo,  Invece, l’indomani, mail dalla Francia: mi scrive un gentilissimo signore, storico e guida in forza al museo – e non solo mi invia una dettagliatissima mappa di Montreuil nel 1565, ma anche una serie di possibilità per i movimenti di Tom nella città. Punti d’ingresso e uscita, luoghi utili, luoghi che all’epoca erano in (ri)costruzione… E un invito a non esitare se ho altre domande. E io di altre domande ne ho, e le pongo, e Monsieur G. risponde, paziente ed esauriente, e manda altro materiale… Alla fine ho capito i miei dubbi su cittadella, città alta e città bassa, so con ragionevole certezza dove va Tom, ho capito dove sbagliavo con i profili della città, e ho di che rendere il Capitolo VI non solo plausibile e accurato – ma, si spera, tridimensionale. Di nuovo: you know what I mean.
Invece, l’indomani, mail dalla Francia: mi scrive un gentilissimo signore, storico e guida in forza al museo – e non solo mi invia una dettagliatissima mappa di Montreuil nel 1565, ma anche una serie di possibilità per i movimenti di Tom nella città. Punti d’ingresso e uscita, luoghi utili, luoghi che all’epoca erano in (ri)costruzione… E un invito a non esitare se ho altre domande. E io di altre domande ne ho, e le pongo, e Monsieur G. risponde, paziente ed esauriente, e manda altro materiale… Alla fine ho capito i miei dubbi su cittadella, città alta e città bassa, so con ragionevole certezza dove va Tom, ho capito dove sbagliavo con i profili della città, e ho di che rendere il Capitolo VI non solo plausibile e accurato – ma, si spera, tridimensionale. Di nuovo: you know what I mean. Ieri sera, con un giorno di ritardo e una certa sorpresa, ho inserito nel taccuino rosso dedicato a Road to Murder il calendario mensile di novembre – una faccenda che è per metà un ruolino di marcia, e per metà resoconto quotidiano di quel che faccio (o non faccio).
Ieri sera, con un giorno di ritardo e una certa sorpresa, ho inserito nel taccuino rosso dedicato a Road to Murder il calendario mensile di novembre – una faccenda che è per metà un ruolino di marcia, e per metà resoconto quotidiano di quel che faccio (o non faccio). Voglio dire: avete un dubbio su come fossero fatte le navi che nel tardo Cinquecento facevano la spola tra Dover e Calais trasportando merci e qualche passeggero per arrotondare? Vi domandate cose come il tipo di costruzione, il numero di alberi e cose così – e, per quanto cerchiate, trovate ben poco di consclusivo, che sia contemporaneo o moderno? Ebbene, quel che fate è scrivere a qualcuno di inglese o di americano. Può essere uno storico che tiene un blog, il curatore di un museo navale, il webmaster di un sito che traccia le rotte commerciali in età Tudor… Scrivete una piccola mail cortese in cui spiegate il vostro dubbio, raccontate a che punto siete riusciti ad arrivare da soli, e formulate la vostra domanda – e… nel giro di qualche giorno, ecco che arriva la risposta! Nella più blanda delle ipotesi, vi indirizzano verso qualche libro o archivio online – ma di solito offrono risposte dettagliate o, dove non ce ne sono, ipotesi ragionate. E vi salutano augurandovi buona fortuna per il romanzo e sperando di essere utili… Ed è meraviglioso.
Voglio dire: avete un dubbio su come fossero fatte le navi che nel tardo Cinquecento facevano la spola tra Dover e Calais trasportando merci e qualche passeggero per arrotondare? Vi domandate cose come il tipo di costruzione, il numero di alberi e cose così – e, per quanto cerchiate, trovate ben poco di consclusivo, che sia contemporaneo o moderno? Ebbene, quel che fate è scrivere a qualcuno di inglese o di americano. Può essere uno storico che tiene un blog, il curatore di un museo navale, il webmaster di un sito che traccia le rotte commerciali in età Tudor… Scrivete una piccola mail cortese in cui spiegate il vostro dubbio, raccontate a che punto siete riusciti ad arrivare da soli, e formulate la vostra domanda – e… nel giro di qualche giorno, ecco che arriva la risposta! Nella più blanda delle ipotesi, vi indirizzano verso qualche libro o archivio online – ma di solito offrono risposte dettagliate o, dove non ce ne sono, ipotesi ragionate. E vi salutano augurandovi buona fortuna per il romanzo e sperando di essere utili… Ed è meraviglioso.